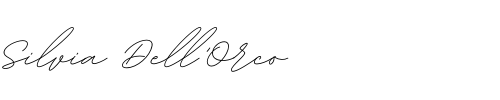Tutti parlano, molti urlano, pochi ascoltano.
Viviamo un tempo in cui parlare sembra più uno sport agonistico che un modo per dare forma ai pensieri.
Ogni mattina, il suono della sveglia è il gong che ci invita a salire sul ring e a parlare. E non possiamo indugiare. Dobbiamo giocare d’anticipo, battere l’altro sul tempo.
È un’epoca in cui il non detto, l’inespresso, l’indicibile sono schiacciati dalla vacuità espressiva, dalla smania di consenso, dalla volgarità, dalla distrazione, dall’audience scambiato per ascolto, da quella sensazione di permanente urgenza in cui stenta a trovare dimora l’umano bisogno di coltivare il dubbio, l’attesa, le domande di senso.
Crediamo di sapere tutto. E, infondo, è vero. Sappiamo tutto del nulla. È qui il grande paradosso: l’accesso illimitato alla conoscenza ci dà la sensazione che la nostra mente sia satura di informazioni e, invece, è una distesa di detriti tanto ingombranti quanto inutilizzabili. Così, per difenderci dallo tsunami informativo che ci travolge ogni giorno, rifuggiamo la complessità, il confronto, l’ascolto considerandoli, per lo più, perdite di tempo.
C'è chi "mente" e chi corpo
Non tutto è dicibile. Vi sono emozioni, inquietudini, pensieri così profondi da vanificare ogni tentativo di esprimerli a parole.
Ecco perchè, più che affannarci a trovare le parole “utili”, forse dovremmo solo risparmiare quelle “inutili”.
Pensiamo, ad esempio, a quella sensazione di disagio o insofferenza che spesso proviamo di fronte ad una persona che soffre. Vorremmo trovare subito la parola magica, quella che solleva, che conforta, che lenisce. Tuttavia, ogni volta che aggrediamo il silenzio e cediamo alla seduzione della parola, decretiamo la fine della comprensione.
Certo, non è facile aspettare che il silenzio si dissolva. Ma, dinanzi al dolore, possiamo sempre affidarci alle declinazioni semantiche del corpo e dare voce ai gesti, agli sguardi, ai sorrisi, alle lacrime, agli abbracci, alle mani che si incontrano. Il corpo può ascoltare, accogliere e raccontare l’indicibile.
Pensiamo ad un rapporto amoroso. Vi è mai capitato, ad esempio, che l’erotismo e la sessualità – da momenti di incontro – si siano trasformati in atti di reciproca alienazione? Vi è successo di percepire che l’altro, ad un certo punto, abbia smesso di ascoltare il vostro corpo? Come se all’improvviso non decifrasse più i vostri desideri, i vostri bisogni, le vostre istanze profonde. Oppure che sia stato il vostro corpo a diventare inaccessibile? Che si sia chiuso e abbia innalzato un muro smentendo le vostre parole?
Ecco, quando le parole raccontano cose che il corpo contraddice…chi sta mentendo?
Thaumazein: la meraviglia che ci apre all'altro
Una delle dimensioni costitutive dell’ascolto – eppure molto spesso sottovalutata – è quella epistemologica.
Forse saremmo molto diversi da quello che siamo se non ascoltassimo solo per comunicare ma, prima di tutto, per conoscere.
Quando ascoltiamo per sottrarci alla nostra ignoranza e per meravigliarci di fronte alle cose che consideravamo ovvie, l’ascolto si trasforma in un prezioso strumento al servizio di quella che Platone e Aristotele chiamavano thaumazein: lo stupore e la meraviglia che ci aprono all’altro, al contatto esplorativo con il mondo.
Quando, al contrario, siamo certi di non aver nulla da imparare, quando siamo distratti, giudicanti, quando abbiamo fretta di arrivare alle conclusioni e interrompiamo il nostro interlocutore: ecco, in tutti questi casi non solo non siamo capaci di ascoltare, ma soprattutto di cogliere una grande occasione di crescita personale.
Chi parla non chiede soluzioni
La mancanza di ascolto è un fiume carsico che si insinua nelle relazioni logorandole lentamente.
Fateci caso. Molti conflitti interpersonali – tra amici, colleghi, partner, familiari – nascono dall’incapacità di ascoltare il punto di vista dell’altro.
A volte crediamo di ascoltare, ma in realtà siamo solo sentinelle in attesa di un tentennamento, di una incertezza dell’interlocutore per insinuarci nel suo discorso e raccontare di noi, dispensare consigli, esprimere giudizi, fare domande o, semplicemente, trovare un modo per congedarci. Spesso ignoriamo il fatto che chi parla non vuole soluzioni. Chiede solo ascolto e comprensione. Dunque, ogni tentativo di condizionare il suo pensiero risponde unicamente al nostro bisogno di vedere le cose in un certo modo.
I consigli, poi – soprattutto quando non richiesti – sono pressoché inutili. È improbabile, infatti, che il nostro interlocutore si calmi, veda il lato positivo della situazione, ragioni o si comporti in un certo modo solo perché gli consigliamo di farlo.
Stessa cosa vale per i giudizi positivi. Questi ultimi – per quanto controintuitivo – restano sempre giudizi e, dunque, possono essere deleteri quanto quelli negativi. Quando, per esempio, vogliamo spronare qualcuno dicendogli che è bravo, capace e che andrà tutto bene, probabilmente gli renderemo più difficile parlarci delle sue fragilità, dei suoi dubbi e di quanto sia profondamente scoraggiato per quella situazione.
Insomma – in un modo o nell’altro – l’ascolto autentico si scontra con quella tendenza ad etichettare l’altro sulla base di ciò che crediamo di sapere di lui, del suo stato d’animo e delle sue intenzioni comunicative.
Così, mentre egli ci parla, noi parliamo di lui a noi stessi, senza mai incontrarlo.
L'ascolto è il seme del cambiamento
Provo sempre un certo disappunto quando mi viene chiesto come si faccia ad ascoltare o quando – come spesso accade in ambito clinico e formativo – si sprechino fiumi di inchiostro o di parole per illustrare le migliori tecniche di ascolto.
Nella mia esperienza, personale e professionale, l’ascolto non è una tecnica, ma una disposizione interiore. È l’espressione di un modo di essere, di una sensibilità che non deriva solo dallo stile comunicativo assorbito dall’ambiente in cui siamo cresciuti, ma soprattutto da una personale consuetudine all’auto-ascolto. Sì, perchè quando ascolto mi ascolto, mi attraverso, intravedo i miei limiti, mi co-costruisco grazie alle parole dell’altro rischiando che queste mi trasformino irrimediabilmente.
Ci sono momenti, ad esempio, in cui ascoltare certe storie sembra un martirio perché ci conducono in territori che non vogliamo esplorare, magari in prossimità di una ferita ancora aperta o di un ricordo doloroso. Ma è questa la grande potenzialità terapeutica dell’ascolto: i racconti dell’altro ci insegnano che nessuna vita è perfetta, che ognuno di noi va incontro a successi, errori, cadute, fallimenti, rinascite.
Ecco perchè l’ascolto autentico è tutt’altro che amorfo e muto. Al contrario, è il seme del cambiamento. È quella porta che ci permette di uscire da noi stessi senza le mappe rassicuranti dei nostri pregiudizi, senza la bussola delle nostre certezze, con un unico obiettivo: perdersi nelle poleis caotiche indicate dalla parola dell’altro e muoversi sul confine che egli ci indica per non sentirsi invaso.
Una volta tornati in noi stessi ci accorgeremo che non ascoltare sarebbe stato molto di più che una mancanza di educazione o di sensibilità nei confronti dell’altro.
Avremo, soprattutto, sprecato una grande occasione di cambiamento e di conversione.